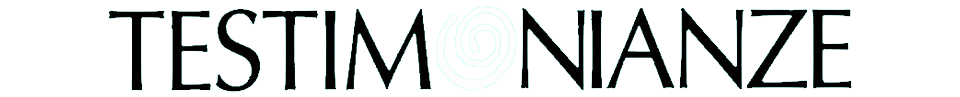di Severino Saccardi
Le nuove tecnologie (di cui l’intelligenza artificiale è una sorta di espressione-simbolo) hanno prodotto una vera e propria rivoluzione antropologica. Bisogna coglierne le nuove potenzialità, sapendo che ci si muove (nell’ambito dell’informazione e della comunicazione, nel rapporto fra nuovi potentati e democrazie e, in generale, sul piano etico) in terra incognita. In questo straordinario contesto, l’Europa è chiamata ad affrontare, in campo aperto, la sfida della transizione digitale facendo riferimento ai valori della democrazia, dei diritti e della dignità della persona.
Una rivoluzione tecnica, e antropologica
Samo in una terra, insieme, già conosciuta e incognita. È la prima considerazione che, spontaneamente affiora leggendo gli interessanti, e sfaccettati, contributi degli amici che, con i loro interventi, hanno collaborato alla realizzazione della sezione tematica di questo volume.
Una realtà double face. Perché da una parte la nuova tecnologia, (con ChatGPT, la robotica più avanzata, le realizzazioni più avveniristiche della multimedialità) è, non solo nota ad un gran numero di persone (giovani o meno giovani), ma, da tantissimi, avvicinata ed usata, con notevole disinvoltura e familiarità. È il mondo nuovo, con le sue inedite forme del comunicare, dell’esprimersi, del modo stesso di percepire la realtà. Una rivoluzione antropologica, forse, prima e oltre che tecnologica. Ma questo mondo nuovo non sappiano cos’è. E non sappiamo quali implicazioni comporterà.
È una sorta di dimensione utopica che, in maniera rapida e incessante, si disvela o è un universo distopico che, in modo sottile e inesorabile, ci avvolge e ci soffoca? Ancora una volta, siamo, a livello planetario, a fare i conti (e stavolta in modo ancor più stringente) con le dimensioni dell’ambivalenza e della complessità. Con l’incalzare della transizione digitale, in cui tutti siamo immersi e con le dirompenti novità prodotte dall’ intelligenza artificiale, i due fronti tornano a schierarsi. Apocalittici o Integrati? La questione non è nuova.
L’impressione, però, ancora una volta, è che il dilemma sia mal posto.
Usare la ruota? «No, grazie!»
Mi è capitato in questi giorni di vedere una simpatica vignetta che riproduceva due uomini «primitivi» che trasportavano a forza di braccia un carretto privo di ruote, con un pesante carico, al che c’è un terzo soggetto che rivela loro la sorprendente novità delle ruote. Ne ha due in mano e le propone ai suoi affaticati interlocutori. Ma questi ultimi rispondono: «No! Grazie! Abbiamo sempre fatto così!». Al di là del sorriso divertito che la risposta suscita nel lettore, se ne potrebbe ricavare qualche interessante riflessione. Intanto, in ogni epoca, il nuovo ha suscitato inizialmente sconcerto.
E la ruota (al di là dell’uso metaforico che se ne può fare, come nella vignetta citata) è stata un grande elemento di rinnovamento nella storia dell’umanità. Si pensi, d’altra parte, che c’erano grandi popoli e civiltà assai evolute e raffinate (come quelle precolombiane: Maya, Aztechi, Incas) che la ruota pare non la conoscessero affatto. Questo, per dire, che cosa, tornando a noi, al nostro, complesso, terzo millennio? Che il problema non è quasi mai la tecnologia in sé. L’avanzamento tecnico (e scientifico) è parte della storia. E meno male che è così. Il problema, diciamo, non è la ruota (il cui uso sgraverà anzi di pesi la schiena dei poveretti adibiti al trasporto dei carichi). In questione è, se mai, l’uso che si farà di quella ruota. Servirà ad un carro che trasporta derrate alimentari o prodotti per il mercato o verrà usata per portare armi, armamenti e truppe che vanno al fronte? L’intelligenza artificiale è, culturalmente parlando, l’invenzione di una fantastica e straordinaria «ruota» nell’età della transizione digitale. Dà strabilianti, e fino a poco tempo fa inimmaginabili, possibilità di lavorare in modo nuovo nell’ambito della scrittura, della grafica, della composizione artistica e di settori importanti e delicati, come quello medico e scientifico.
Certo, è una dimensione che impone di ridefinire non pochi paradigmi. Pur essendo, essa stessa problematica da definire nella sua essenza di fondo. È vera «intelligenza»1? Ha potenzialità enormi. O, più ancora che enormi, strabilianti. Ma, questo è vero, non ha le doti dell’individualità, della creatività, dell’originalità che caratterizzano l’essere umano. In questo senso, come viene puntualmente riconfermato anche in questo volume, scrittori, artisti, poeti possono stare tranquilli. L’intelligenza artificiale non ruberà loro il mestiere. Offrirà possibilità straordinarie a chi ne saprà utilizzare (nel bene o anche nel male, ahimè) le risorse. Ma la scintilla dell’inventiva umana serberà il suo ruolo. Certo, sarà tutto anche moto più arduo.
Distinguere il vero dal falso
Distinguere il vero dal falso, per esempio. È un aspetto che viene molto sottolineato e che, molto, giustamente, inquieta. Ne è un esempio un fatto recente, di cui nella cronaca (o nel gossip) di carattere politico, si è recentemente parlato. Un fatto a cui rimanda uno dei gustosi trafiletti de Il Caffè di Massimo Gramellini. Che ha l’azzeccato titolo: Un bacio quasi falso. La vicenda è, appunto, nota. Su «milioni di telefoni è apparso il video che immortala Elon Musk, a Parigi, per l’inaugurazione di Notre Dame, mentre si volta di scatto e bacia appassionatamente Giorgia Meloni». Vero? Falso? «“Quasi certamente Intelligenza Artificiale”, ha commentato un utente, e in quel “quasi” c’è la condizione dell’uomo contemporaneo (…). In questo meccanismo governato dalla fretta, persino l’idea che Musk e Meloni stiano insieme e abbiano deciso di uscire dalla clandestinità proprio durante un ricevimento all’Eliseo perde la sua improbabilità e diventa un’ipotesi, se non credibile, quantomeno percorribile; ma soprattutto immediatamente commentabile».
Da una parte di tutto si diffida perché tutto è manipolabile, ma dall’altra ci si trova in un contesto in cui, paradossalmente, anche la credulità aumenta a dismisura. Non so se abbia ragione l’autore del trafiletto che conclude che abbiamo creato «(…) un’altra arma devastante in grado di (…) rovinare la vita ai più fragili»2.
Certo, che bisognerà, in materia, essere assai vigili. Già da tempo viviamo in un contesto connotato da segnali e fenomeni inquietanti nel mondo della comunicazione e dell’informazione. Esiste, talora, ed ha largo corso la «verità» separata dai fatti3. Sono aspetti che la nuova realtà delle cose (e la potenza inusitata della tecnologia) rischia, evidentemente, di estendere e di amplificare. Ne possono derivare rischi non da poco per le sorti stesse della democrazia.
Nuovi potentati
Ci sono nuovi potentati transnazionali (come ha detto anche il nostro presidente della Repubblica, in un trasparente passaggio del suo intervento alla cerimonia con gli ambasciatoti dello scorso 16 dicembre) che, in una certa dimensione, sembrano assumere un peso smisurato. Come comportarsi, dunque, di fronte alle ambivalenze di una situazione così nuova? È il grande quesito dei nostri tempi in relazione al quale anche questo nostro volume (con l’apporto degli amici che vi hanno scritto) prova a dare un contributo. In causa è chiamata, certamente, l’Europa. Che è convocata a scelte di fondo. Scelte su cui la discussione è aperta ed è ben viva. L’Europa, come in più di un passaggio è stato richiamato, non può, anche in relazione a questa delicata e centrale materia, che ispirarsi ai suoi principi di fondo. La democrazia, i diritti, la dignità della persona, il senso delle regole. E anzi, le regole, come viene ricordato, l’Unione europea le ha scritte e sta cercando ulteriormente di definirle.
Non è poco, in un mondo che troppo spesso appare privo di regole. Certo, bisogna fare attenzione a non creare lacci, impacci e pastoie burocratiche che possano creare non poco danno in un tempo in cui tutto si gioca sulla rapidità, la scioltezza, la corsa costante contro e oltre gli ostacoli.
Sarebbe micidiale e suicida derogare dai principi e valori di fondo (che sono l’essenza stessa della democrazia e della parte migliore della nostra storia), ma è imperativo anche essere all’altezza delle questioni poste dalla transizione digitale.
Il passaggio è stretto ed il cammino è arduo. Ma è in quella direzione, e con il passo giusto, che non può non muoversi la casa comune europea (che tale deve decidersi ad essere) di fronte alle sfide del «mondo globale».
1 È quanto si chiede, per esempio, M. Salucci in un articolo dal titolo Perché la chiamate intelligenza?, «Testimonianze», nn. 557-558. Di M. Salucci v. anche: Se l’intelligenza artificiale è come Giano bifronte, «Testimonianze», n. 554.
2 M. Gramellini, Un bacio quasi falso, rubrica «Il Caffè», «Corriere della sera», 10 dicembre 2024.
3 V. La «verità» separata dai fatti, sez. monotematica (a cura di F. Dei, P. Meucci P. Pedani e S. Saccardi) di «Testimonianze», nn. 528-529.