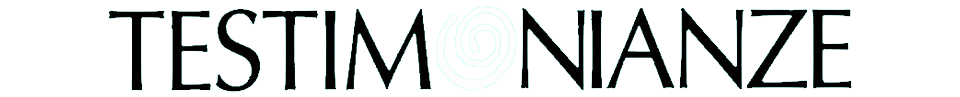di Luisa Damiano, Antonio Fleres, Rebecca Mannocci
Il settore della robotica, con lo sviluppo di modelli di robot sempre più «autonomi», pone una serie di problemi di carattere etico. Una questione evidenziata dalla mozione Delvaux al Parlamento europeo (approvata, ma non vincolante), che ha posto il problema della definizione dello status di persona elettronica. Ma gli specialisti, pur riconoscendo l’insorgere di questioni etiche nel proprio lavoro, ritengono tale definizione avulsa delle reali problematiche inerenti alla materia, essendo disgiunta dalle attività di ricerca e implementazione della robotica svolte «sul campo». È auspicabile, quindi, una sinergia fra i rispettivi campi di ricerca, per lo sviluppo di una robo-etica come dimensione transdisciplinare, orientata ad affrontare le sfide poste da tale innovativa tecnologia.
L’interazione fra esseri umani e robot
La diffusione dei robot nei nostri contesti sociali ha progressivamente ricollocato le questioni etiche legate alla robotica, spostandole dai margini al centro del dibattito scientifico. Una gamma crescente di discipline si sta impegnando in ricerche inerenti all’interazione tra esseri umani e robot puntate su preoccupazioni sociali di ampio respiro. Sebbene l’indagine filosofica, tradizionalmente associata alla riflessione etica, giochi un ruolo cruciale, anche la robotica e l’ingegneria si stanno sempre più rivolgendo all’esplorazione di questioni di carattere etico. Un orientamento che, a partire dall’inizio del nuovo millennio, da un lato, ha favorito lo sviluppo di una linea della ricerca etica specificamente dedicata alla robotica, detta «robo-etica», e, dall’altro, ha prodotto l’esigenza di nuove integrazioni inter e transdisciplinari, atte a supportarne l’evoluzione1.
Oggi l’interesse per lo sviluppo di un’etica della robotica è accentuato dai rapidi progressi scientifici e tecnologici in aree di frontiera come la Human-Robot Interaction (HRI) e la robotica sociale. Si tratta di ambiti in cui la progettazione di robot si articola non più solo sul paradigma classico operatore-macchina, ma anche sul nuovo paradigma della comunicazione umano-macchina «socialmente evocativa». Accanto agli strumenti robotici, emergono robot disegnati per comunicare con noi attraverso segnali sociali compatibili con i nostri – sguardi, gesti, parole… L’idea è quella di «partner sociali» artificiali per noi umani2; agenti robotici che, comunicando con noi con le nostre modalità, sono facilmente integrabili nei nostri contesti sociali, pubblici e domestici, ove possono svolgere compiti di rilevanza sociale quali mediazione terapeutica ed educativa, assistenza ad personam, training e coaching3. Questo scenario, sempre più attuale, implica che i robot possano influenzare in modo significativo diversi aspetti della nostra vita e della nostra co-esistenza. Il ricorso a questi agenti artificiali sta ampliando e trasformando il modo in cui produciamo beni e servizi, ma non solo. La loro introduzione nei contesti della nostra quotidianità, in qualità di nuovi «attori sociali», sta attivando cambiamenti anche nel nostro mondo sociale; movimenti metamorfici che possono arrivare a toccare i modi in cui percepiamo, concepiamo e definiamo la nostra socialità e la nostra stessa identità in quanto soggetti di processi sociali4. È un contesto che impone l’esigenza di un’indagine etica approfondita, mirata a garantire la «sostenibilità sociale» della diffusione dei robot5.
In lavori di ricerca condotti in precedenza6, sono stati evidenziati aspetti critici dell’indagine etica contemporanea sui robot che ostacolano la produzione di risposte significative a questa esigenza.
Mancanza di integrazione disciplinare efficace. I ricercatori attivi in ambiti disciplinari tradizionalmente impegnati nell’affrontare questioni etiche non sempre sono informati sugli effettivi sviluppi teorici, metodologici e implementativi delle indagini che si svolgono nel quadro della robotica. Al contempo, gli specialisti in queste aree, dotati di una conoscenza approfondita dei robot e dell’interazione umano-robot, spesso non dispongono delle competenze necessarie allo sviluppo di indagini di carattere etico.
Mancanza di conoscenze multi-, inter- e transdisciplinari. Attualmente la letteratura inerente ai robot tende a concentrarsi principalmente su aspetti tecnici. Le esplorazioni che considerano altre dimensioni dei processi di produzione, integrazione e impatto sociale dei robot – dimensioni antropologiche, psicologiche, socio-culturali, politiche, ontologiche, epistemologiche, ecc. – sono ancora in fase di gestazione e non convergono in approcci condivisi per condurre indagini etiche.
Determinismo tecnologico. Il dibattito etico tende a considerare i contesti sociali trascurando le dinamiche di co-determinazione tra robotica e società insite nello sviluppo dei robot7.
Resistenza alla creazione di novità etiche. Le linee di ricerca impegnate nella riflessione etica sui robot manifestano la tendenza a trattare le questioni emergenti dell’etica della robotica con approcci etici preesistenti, sviluppati per affrontare problematiche completamente diverse. Per esempio, è frequente il ricorso ai quadri etici elaborati nel campo della bioetica.
Stagnazione del dibattito etico. Il dibattito appare spesso polarizzato in una sterile alternativa tra «tecno-entusiasmo» e «tecno-fobia»8.
Mancanza di linee guida praticabili. Molte ricerche etiche focalizzate sulla robotica, soprattutto in ambiti emergenti di particolare interesse quali la robotica sociale, tendono a produrre una condanna generale della tecnologia robotica target. Sviluppano cioè riflessioni etiche che, intervenendo a posteriori, rifiutano a priori l’intera produzione della ricerca robotica di riferimento, risultando così destinate a rimanere inascoltate9.
Un lavoro di indagine
A fronte della crescente rilevanza assunta dalle questioni etiche relative all’uso delle tecnologie robotiche, queste lacune indicano che, allo stato attuale, l’ambito della robo-etica non può ancora esprimere risposte efficaci alle sfide che la diffusione dei robot oggi ci impone. Benché la comunità dell’ingegneria si stia aprendo sempre più spesso all’etica della robotica, recenti analisi denunciano un significativo disaccoppiamento tra indagine robotica e indagine etica. In uno studio del 2020, Zawieska10 riconduce questo disallineamento al fatto che la maggior parte degli ingegneri ritiene che le questioni etiche inerenti alla ricerca robotica non siano sufficientemente rilevanti da richiedere specifiche indagini; un posizionamento che Zawieska riconduce alla mancanza, nel percorso di studi tipicamente proposto a questi specialisti, di formazione in campo etico. Secondo Zawieska, questi fattori implicano che gli ingegneri tendano a considerare l’etica come un campo estraneo al loro ambito specialistico, tanto da aumentare il rischio di processi di disumanizzazione e svalutazione dell’umano. Lo studio di Zawieska converge così nell’indicare che l’obiettivo di portare la robo-etica a costituirsi come un ramo maturo dell’indagine etica implichi rinnovarla in modo integrativo e in base ad approcci multi, inter e trans-disciplinari.
Queste considerazioni hanno costituito il punto d’origine di un lavoro di indagine condotto dal nostro gruppo di ricerca mediante la strutturazione di una collaborazione transdisciplinare11. Si tratta di uno studio diretto a esplorare la percezione che gli specialisti in robotica hanno dei tentativi di regolamentazione etica del loro campo. L’indagine si focalizza sulla mozione Delvaux, che nel 2016 ha portato all’attenzione del Parlamento europeo una proposta di regolamentazione etica della robotica. Lo studio, presentato in queste pagine in alcuni dei suoi aspetti salienti, si è articolato su un approccio metodologico basato su due scelte complementari. Da un lato, si tratta dell’opzione di sviluppare un’analisi qualitativa e quantitativa della percezione dei ricercatori in robotica a riguardo delle questioni etiche chiave oggetto della mozione. Dall’altro lato, si tratta dell’adozione di un approccio embedded, o immersivo, diretto all’obiettivo di colmare la distanza tra indagine etica e indagine robotica. Lo studio è stato condotto attraverso la partecipazione attiva di un ricercatore in filosofia della robotica a ricerche svolte nell’ambito della robotica stessa, all’interno di alcuni laboratori europei. Durante queste visite di ricerca «immersive», il ricercatore ha somministrato questionari a specialisti in robotica, raccogliendo le loro opinioni sulla mozione in causa12.
La mozione Delvaux al Parlamento europeo
Il Comitato per gli affari giuridici del Parlamento europeo, a partire dal 2016, ha elaborato diverse proposte per la regolamentazione della robotica nell’Unione europea (UE). Queste sono state presentate da Mady Delvaux al Parlamento europeo, sotto forma di una mozione, il 31 maggio 201613. La mozione Delvaux, definita anche «Draft report on civil law rules on robotics», punta a un duplice obiettivo: stabilire regolamenti per il settore della robotica in tutta l’UE e fornire un quadro etico comune per i paesi membri.
Le principali proposte contenute nel Draft report, particolarmente rilevanti per gli obiettivi di questo articolo, possono essere riassunte come segue.
Creazione di un nuovo status giuridico per i robot, denominato «persona elettronica». Si tratta di una delle più significative, controverse e dibattute proposte della mozione Delvaux. In sostanza, secondo il Draft report, il nuovo status giuridico di persona elettronica dovrebbe essere attribuito ai robot autonomi più avanzati, conferendo loro «diritti e obblighi». Tali agenti robotici dovrebbero essere sufficientemente autonomi da interagire in modo indipendente con terze parti. Il Comitato per gli affari giuridici sostiene che l’ascrizione ai robot dello status di persona elettronica risolverebbe il problema della responsabilità, consentendo di attribuire a questi artefatti la responsabilità delle proprie azioni e l’obbligo di risarcire eventuali danni causati.
Creazione di un’agenzia UE per la robotica e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale dell’agenzia a cui fa riferimento la mozione sarebbe fornire competenze tecniche, etiche e normative a supporto degli attori pubblici competenti, garantendo una risposta adeguata allo sviluppo tecnologico nell’ambito della robotica. L’agenzia UE per la robotica sarebbe dotata di un budget consono e di personale esperto proveniente da diversi settori legati alla robotica, così da coprire aspetti tecnici, etici e legali.
Definizione di «robot intelligente». Il Draft report propone una definizione di «robot intelligente» basata su quattro caratteristiche distintive: la capacità di acquisire autonomia attraverso sensori e/o scambiando dati con l’ambiente e analizzando tali dati; la capacità di apprendere attraverso l’esperienza e l’interazione; un supporto fisico di tipo robotico; la capacità di adattare azioni e comportamenti all’ambiente. L’ultima versione del Draft report ha introdotto una quinta caratteristica: la mancanza di vita biologica.
Registrazione dei robot intelligenti. La mozione Delvaux propone di registrare tutti i «robot intelligenti» diffusi nell’UE al fine di tracciare ogni robot intelligente presente e così facilitare l’implementazione di eventuali raccomandazioni future. La registrazione prospettata nel Draft report si baserebbe sulla definizione sopra menzionata di robot intelligente.
Carta della robotica. Questo documento costituisce il nucleo etico del Draft report. Propone un quadro etico comune per tutti i paesi dell’UE. La Carta è articolata in quattro parti: un codice di condotta per ingegneri robotici, un codice per i comitati etici di ricerca, una licenza per i progettisti e una licenza per gli utenti. Il preambolo del codice di condotta per ingegneri robotici stabilisce quattro principi etici fondamentali, mutuati dalla bioetica: beneficenza, non maleficenza, autonomia e giustizia14.
Inoltre, viene proposta una seconda serie di principi specifici per la ricerca in robotica, tra cui: rispetto dei diritti fondamentali, precauzione, inclusività, privacy, responsabilità, sicurezza, reversibilità, massimizzazione dei benefici e minimizzazione dei danni.
Reddito di base universale. Il Draft report suggerisce l’implementazione di un reddito di base universale per contrastare gli effetti potenzialmente negativi che gli sviluppi della robotica e dell’IA potrebbero avere sui mercati del lavoro e sull’occupazione nell’UE.
Il Parlamento europeo ha votato le proposte del Draft report il 16 febbraio 2017. Questa votazione, priva di ogni valore vincolante, ha trovato uno dei risultati più significativi nell’approvazione della controversa proposta di creazione dello status giuridico di persona elettronica per i robot autonomi più sofisticati15. Tuttavia, sin dalla sua presentazione, il Draft report ha attivato un dibattito molto acceso non solo nel contesto politico, ma anche in quello accademico. Ad esempio, Natalie Nevejans ha pubblicato uno studio che analizza dettagliatamente il documento. Pur riconoscendone l’innovatività, Nevejans mette in evidenza dei significativi punti deboli16, tra cui annovera in particolare la creazione dello status giuridico di persona elettronica, ritenuto potenzialmente dannoso per i diritti delle persone.
Quel che pensano i ricercatori
I dati demografici raccolti grazie alla somministrazione dei questionari, precedentemente menzionati, ai ricercatori in robotica sociale mostrano che questa area della robotica è intrinsecamente interdisciplinare, anche se la maggior parte delle componenti disciplinari coinvolte è collocata nel campo delle scienze STEM. Nonostante il background interdisciplinare, il 75% dei ricercatori a cui sono stati somministrati i questionari si è identificato come «esperto in robotica». Abbiamo inoltre valutato il livello accademico dei partecipanti, rilevando che erano rappresentati tutti i livelli accademici, dagli studenti di laurea magistrale ai professori ordinari. La distribuzione dei livelli nel nostro campione rispecchia quindi la struttura accademica ed è rappresentativa dei diversi livelli accademici che si possono trovare in un laboratorio universitario di ricerca. Il questionario, concernente aspetti della mozione Delvaux, conteneva sia domande chiuse, rispetto a cui le risposte possibili potevano essere «sì», «no» o «astensione», sia domande aperte.
La prima domanda del nostro questionario esplorava la possibilità che i partecipanti fossero a conoscenza dell’esistenza del Draft report prima del seminario. Solo il 42% dei partecipanti aveva sentito parlare di questo documento. Il 56% dei partecipanti non ne aveva mai sentito parlare e il 2% si è astenuto dal rispondere. Questo evidenzia che, in generale, gli esperti in robotica non prestano necessariamente attenzione a ciò che accade in campi correlati al loro e, in particolare, nell’ambito etico e normativo inerente al loro campo. Ciò suggerisce anche che, in generale, la maggior parte dei ricercatori in robotica tende a concentrarsi su aspetti primariamente tecnici degli artefatti che produce.
Alla domanda se avessero mai riconosciuto l’emergere di un dilemma etico nel loro lavoro, solo il 33% dei partecipanti ha risposto positivamente, mentre il 63% ha risposto di non aver mai incontrato dilemmi etici e il 4% si è astenuto. In altri termini, nonostante la maggioranza affermi di non aver incontrato dilemmi morali durante lo svolgimento delle proprie attività di ricerca e implementazione in robotica, un terzo dei partecipanti ha dichiarato di aver incontrato dilemmi etici durante il proprio lavoro o di conoscere persone nel campo che li hanno affrontati. Considerando che i dilemmi morali devono essere considerati eccezioni, possiamo affermare che i ricercatori in robotica incontrano un alto tasso di preoccupazioni etiche nel proprio percorso professionale. Questi risultati sono confermati dai dati delle domande aperte, che seguono la stessa tendenza. Abbiamo organizzato le domande aperte in tre aree: il tema della persona elettronica, il ruolo dell’etica per i ricercatori e le percezioni dei robotici riguardo alla comprensione dei politici.
Persona elettronica
I partecipanti hanno risposto in modo molto chiaro alla domanda sull’introduzione dello status di persona elettronica: la maggioranza si oppone all’idea e non la ritiene necessaria. Questo evidenzia che la comunità dei robotici è consapevole del fatto che attualmente non esistono, e non esisteranno nel prossimo futuro, robot che possano soddisfare la nozione di persona elettronica. Su queste basi, il nuovo status giuridico proposto dalla mozione Delvaux è considerato «privo di senso». In secondo luogo, i partecipanti hanno enfatizzato che questo tipo di iniziativa è fortemente influenzato, più che da conoscenze e framework di carattere scientifico, da pregiudizi provenienti da fonti non strettamente scientifiche, quali la fantascienza; pregiudizi che possono allontanarsi molto dai problemi reali della robotica attuale. Infine, il campione della comunità dei robotici che ha compilato i questionati appare riconoscere che i problemi etici attuali nell’ambito della robotica riguardano aspetti dei robot significativamente diversi da quelli legati all’idea che gli agenti robotici siano definibili come persone elettroniche.
Quattro posizioni
Le risposte a riguardo del ruolo dell’etica sono state ricondotte a quattro opzioni: nessun rischio; necessità solo per l’accettazione da parte degli utenti; rischio reale e l’etica dovrebbe essere applicata perché gli esseri umani in generale dovrebbero comportarsi eticamente. Le risposte della categoria «nessun rischio» riportano le seguenti argomentazioni: «i robot non sono abbastanza sviluppati per rappresentare una minaccia»; «altri si occuperanno della regolamentazione»; «i robot sono come qualsiasi altra tecnologia (pongono pericoli simili): anche le auto possono uccidere e anche i telefoni cellulari rappresentano una minaccia per la società; «mancanza di consapevolezza delle qualità specifiche dei robot (sociali)».
Etica e robotica: un dialogo possibile?
Lo studio di cui stiamo sintetizzando gli esiti mette in luce che uno dei problemi centrali da risolvere per strutturare un approccio etico efficace alla regolamentazione etica della robotica è la questione del dialogo tra le discipline coinvolte. La ricerca svolta mostra infatti che l’approccio alla regolamentazione etica della robotica, in sviluppo presso l’UE, è disgiunto dalle attività di ricerca e implementazione svolte nell’ambito della robotica. La maggior parte degli specialisti in robotica non è a conoscenza di tali processi e, quando ne viene informata, spesso non condivide le proposte avanzate e le considera incapaci di riflettere lo stato della ricerca e della produzione tecnologica nel campo. Nonostante ciò, è chiaro che gli specialisti in robotica sono disposti a impegnarsi nel rispettare un codice deontologico obbligatorio per la loro professione, come accade per altre professioni riconosciute. Al di là delle diverse posizioni assunte, molti di questi ricercatori si dichiarano aperti a una regolamentazione etica delle loro attività di ricerca e implementazione ed esprimono la necessità di una maggiore presenza dell’etica nel proprio campo. A livello metodologico, lo studio suggerisce che un approccio immersivo alle questioni etiche nella robotica può essere fruttuoso in due principali direzioni. In primo luogo, può facilitare gli specialisti in etica e in filosofia della scienza nello stabilire un dialogo con i ricercatori del campo target delle loro indagini. In seconda istanza, può offrire agli specialisti in robotica uno stimolo non solo all’estensione delle loro prospettive e conoscenze al di fuori del campo STEM, ma anche all’approfondimento della consapevolezza del circuito di co-determinazione che interconnette la tecnologia che producono ai contesti sociali in cui essa è sviluppata e diffusa17.
Su questa base, si può pensare all’approccio immersivo come a un supporto metodologico in grado di facilitare la soluzione di alcune delle criticità che oggi ostacolano lo sviluppo della robo-etica.
Mancanza di integrazione disciplinare efficace. L’approccio immersivo richiede allo specialista in etica e in filosofia della scienza non solo la presenza fisica, ma anche la collaborazione attiva nelle attività caratteristiche dei laboratori di robotica, così da aumentare la possibilità di trasmissione bidirezionale di conoscenze.
Stagnazione del dibattito etico sulla robotica. L’approccio metodologico in causa può fornire agli specialisti in etica e in filosofia della scienza una conoscenza adeguata della tecnologia robotica attuale, aiutandoli a strutturare una via alternativa, riflessiva e critica, agli estremi del tecno-entusiasmo e della tecno-fobia che oggi polarizzano il dibattito etico sulla robotica.
Mancanza di conoscenze transdisciplinari sul circuito di co-determinazione tra robotica e società. L’approccio immersivo, inserendo specialisti in discipline umanistiche nei laboratori di robotica, può trasformare questi ultimi in luoghi di sviluppo di angolazioni di indagine, ulteriori rispetto a quella centrata su aspetti tecnici, per esplorare le interazioni umano-robot.
Determinismo tecnologico. Su questa base, l’approccio immersivo può mitigare la tendenza del dibattito etico sulla robotica a chiudersi nelle posizioni del determinismo tecnologico e favorire la consapevolezza della complessa dinamica di co-determinazione che ci interconnette alla tecnologia robotica che produciamo.
Mancanza di impegno nella definizione di linee guida per uno sviluppo sostenibile della robotica. Tale approccio, richiedendo ai ricercatori in etica e filosofia della scienza di partecipare attivamente alle attività di ricerca e implementazione sviluppate nell’ambito della robotica, può contribuire a invertire la tendenza a produrre una riflessione etica «a cose fatte». Più profondamente, può favorire lo sviluppo di una esplorazione filosofica ed etica che sia in grado di accompagnare criticamente l’intero percorso di sviluppo della ricerca e dell’implementazione in cui si esprime la produzione tecnologica della robotica contemporanea. Su queste basi, l’approccio immersivo può rappresentare una pratica di ricerca utile allo sviluppo della robo-etica come movimento transdisciplinare, orientato ad affrontare le sfide di cui è portatrice la tecnologia robotica in base a co-esplorazioni multilivello, svolte partecipativamente da ricercatori in etica e ricercatori in robotica.
1 G. Veruggio, The birth of roboethics, in International conference on robotics and automation, Workshop on roboethics, 2005.
2 T. Fong, I. Nourbakhsh, K. Dautenhahn, A survey of socially interactive robots, «Robot and Autonomous Systems», 42(3-4), 2003, pp. 143-166; K. Dautenhahn, Socially intelligent robots: dimensions of human-robot interaction, «Philosophical Transactions of the Royal Society B», 362, 2007, pp. 679-704.
3 S. B. Daily, M. T. James, D. Cherry, J. J. Porter, S. S. Darnell, J. Isaac, T. Roy, Affective computing: historical foundations, current applications, and future trends, «Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction», 2017, pp. 213-231.
4 J. Seibt, R. Hakli, M. Norsko, Sociable robots and the future of social relations, IOS Press Ebooks, 2014; L. Damiano, Homes as human-robot ecologies: an epistemological inquiry on the “domestication” of robots, in The Home in Digital Age, Routledge, Londra 2021.
5 J. Khakurel, B. Penzenstadler, J. Porras, A. Knutas, W. Zhang, The rise of artificial intelligence under the lens of sustainability, «Technologies», 6(4), 100, 2018.
6 L. Damiano, Homes as human-robot ecologies: an epistemological inquiry on the “domestication” of robots, cit.; L. Damiano, P. Dumouchel, Anthropomorphism in human-robot co-evolution, «Frontiers in Psychology», 9(MAR), pp. 1-9, 2018.
7 L. Damiano, Homes as human-robot ecologies: an epistemological inquiry on the “domestication” of robots, cit.; B. Dunstan, The plastic dynamism of the human aesthetic: employing futurist metodologies in the cross-disciplinary, PhD thesis, University of New South Wales, Sydney.
8 R. Jones, “If it’s not broken, don’t fix it?” An inquiry concerning the understanding of child-robot interaction, in What Social Robots Can and Should do, IOS Press Ebooks, 2016, pp. 89-98.
9 L. Damiano, P. Dumouchel, Emotions in relation. Epistemological and ethical scaffolding for mixed human-robot social ecologies, «Humana.Mente», 13(37), pp. 181-206, 2020; L. Damiano, P. Dumouchel, Anthropomorphism in human-robot co-evolution, cit.
10 K. Zawieska, Disengagement with ethics in robotics as a tacit form of dehumanisation, «AI & SOCIETY», 35.4, 2020, pp. 869-883.
11 A. Fleres, L. Veling, F. Broz & L. Damiano, Integrative Robo-Ethics: Uncovering Roboticists’ Attitudes to Ethics and Moving Forward, «International Journal of Social Robotics», 15(12), 2023, pp. 2019-2037. Lo studio ha coinvolto specialisti in filosofia ed etica della robotica, specialisti in robotica sociale e HRI e specialisti in antropo-sociologia.
12 Le specificità dell’approccio immersivo qui menzionato sono descritte in dettaglio nell’articolo di Antonio Fleres, Louise Veling, Frank Broz & Luisa Damiano, Integrative Robo-Ethics: Uncovering Roboticists’ Attitudes to Ethics and Moving Forward, cit.
13 M. Delvaux, Draft report with recommendations to the commission on civil law rules on robotics (2015/2103(INL), Technical report, committee on legal affairs, European Parliament, PE582, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect,
(ultimo accesso: 17/10/2024).
14 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of biomedical ethics, Oxford University Press, Oxford 2012.
15 L’unico effetto concreto della mozione sulla regolamentazione della robotica risale al 2019 e risiede nell’emanazione, da parte del Parlamento europeo, di una risoluzione non vincolante sulle politiche industriali relative all’IA e alla robotica, consultabile al sito web: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html (ultimo accesso: 17/10/2024).
16 N. Nevejans, European civil law rules in robotics. Study for the JURI committee, technical report, European Parliament, 2016.
17 S. Šabanović, Robots in society, society in robots: Mutual shaping of society and technology as a framework for social robot design, «International Journal of Social Robotics», 2.4, 2010, pp. 439-450; L. Damiano, Mente, robot ed ecologie sociali miste. Per un’epistemologia sperimentale dei robot sociali, «Sistemi intelligenti», 32.1, 2020, pp. 27-39.